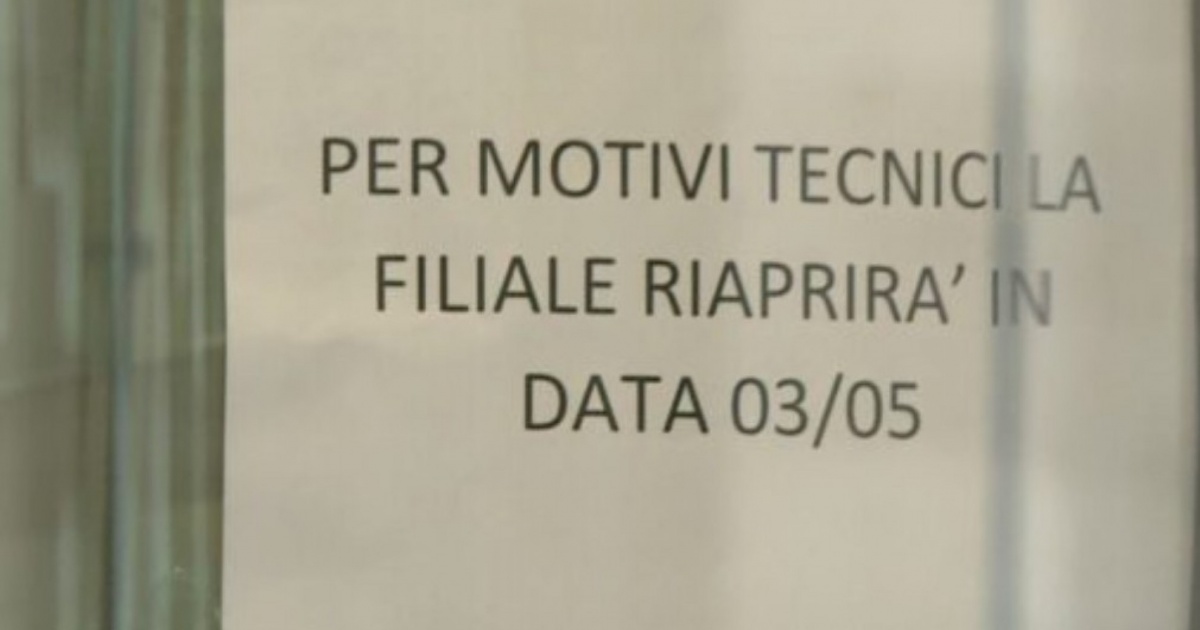La campagna di Libia
A colloquio con Francesco Schiavi dell'Ispi di Milano: un Paese lacerato tra guerra per procura, disputa per le risorse e conflitto civile

Non sono bastati nove anni a rimettere insieme i cocci della Libia devastata dall’intervento concertato tra Europa e Stati Uniti per far fuori Muhammar Gheddafi, l’autocrate più longevo del Nord Africa. Piuttosto, il processo di disgregazione, cinicamente chiamato “rivoluzione”, si è rivelato funzionale a disegni che ben poco avevano a che fare con la “liberazione” del popolo libico. Come sembra confermato dal crescente numero di attori che in Libia si disputano la scena, ma soprattutto influenze e risorse.
Subito dopo la Conferenza di Berlino, le cui conclusioni sono ben vaghe, è parso confermarsi che vi è un “fronte interno” libico, le cui dinamiche non sono necessariamente le stesse del “fronte estero”, affollatissimo di attori. Non è che la definizione di proxy war per quanto avviene in Libia è insufficiente? E che accanto a una guerra per procura vi si conduce una vera guerra intestina?
Senza dubbio si tratta di una proxy war, seppur gli attori coinvolti siano tanti e tutti con agende diverse e talvolta conflittuali. D’altro canto, non si può leggere la crisi libica come una guerra condotta unicamente da potenze esterne. Noi stessi intendiamo sovente la guerra civile come un conflitto tra le forze di al-Serraj e Haftar, ma in realtà a detenere il controllo effettivo sul terreno sono le milizie. Un quadro, in questo senso, immutato sin dal periodo immediatamente successivo alla caduta di Muhammar Gheddafi nel 2011, quando non vi fu un reale disarmo delle milizie. Al contrario, il loro numero è andato in crescendo : se durante le proteste contro il regime di Gheddafi si contavano approssimativamente trentamila miliziani, oggi si stima che il loro numero sia cresciuto sino ad almeno 250mila. Va anche aggiunto che lo stesso Lna (l’Esercito nazionale libico), agli ordini di Khalifa Haftar, e il Governo di unità nazionale (Gna) che risponde a Fayez al-Serraj non dispongono di vere forze armate unitarie: in entrambi i casi si tratta infatti di un insieme variegato di milizie che, per diversi motivi e interessi – economici o ideologici – hanno deciso di supportare una fazione o l’altra, formando per altro alleanze del tutto fluide e mutevoli.
Parliamo quindi di realtà fortemente radicate sul territorio, nate come movimenti rivoluzionari in opposizione al regime, ma che nel tempo si sono trasformate finendo per esercitare una forte influenza locale e che spesso sopperiscono alla mancanza dello stato (ad oggi mai interamente ricostituito). In questo modo, le milizie si sono ritagliate un ruolo di controllo delle rispettive aree d’influenza, in settori che spaziano dalla sicurezza fino alla gestione di traffici illeciti (di migranti, armi, o droga).
Questa distribuzione del potere su base territoriale è forse il retaggio di un’organizzazione clanica della società libica, che precede e segue il regime di Gheddafi?
Ad oggi, le dinamiche interne alle realtà clanicotribali – in senso esteso – sono da intendersi come quelle di una famiglia allargata. In un contesto in cui il controllo dello stato si indebolisce o cessa di esistere e in cui la sicurezza passa in mano a diversi gruppi armati, le cui identità e lealtà non sono mai facilmente riconoscibili, è chiaro che una delle forme di aggregazione sociale a cui si fa ritorno è quella delle realtà familiari. Sappiamo che, all’indomani della guerra civile, vi fu un grande sviluppo di localismi: grosse congregazioni sulla base delle affiliazioni tribali, così come la formazione di vere città-stato, nel tentativo di assolvere a ruoli e servizi che normalmente sono gestiti e dispensati dallo stato. Lealtà, dunque non necessariamente di natura ideologica o confessionale.

Muhammar Gheddafi fu la massima autorità libica per quarant'anni (Keystone)
Turchia e Russia sono in potere di “controllare” i rispettivi protetti? Se in Siria sono riusciti in qualche modo a mascherare le contraddizioni delle rispettive politiche, vi riusciranno anche in Libia?
In Libia gli attori esterni rivestono un ruolo importante, la cui influenza cambia da attore ad attore, per intensità e forma di aiuto alle rispettive parti. Sappiamo ad esempio che la Turchia è un partner importante di Tripoli almeno dal 2015. Oggi il suo ruolo appare in crescita soprattutto per la decisione di inviarvi truppe; non va comunque dimenticato che da lungo tempo Ankara assicura a Tripoli un consistente aiuto economico e militare, insieme al Qatar. Di recente, Erdogan si è deciso ad andare “boots on the ground” a causa della precaria situazione in cui verte il governo di unità nazionale. Quanto alla Russia, il suo ruolo (dal 2017 a fianco di Haftar) è sempre stato importante, pur avendo mantenuto un atteggiamento prudente. Soltanto dalla nuova offensiva del 4 aprile l’impegno di Mosca è cresciuto, ma non in misura paragonabile al ruolo svolto dagli Emirati o dall’Egitto nel sostenere Haftar.
Se oggi si parla di un maggiore attivismo turco e russo, ciò è principalmente dovuto alla recente scelta di questi di fornire alle rispettive parti un decisivo supporto militare. Lo si è visto quando l’autunno scorso i contractor russi del Gruppo Wagner sono intervenuti nei principali teatri di scontro, accelerando l’evoluzione dei combattimenti in Tripolitania. È stato allora che Erdogan ha reagito per salvaguardare la propria sfera di influenza in Libia, accrescendo le forze a protezione di al Serraj, con cui ha stretto importanti accordi commerciali, primi fra tutti quelli relativi alla ridefinizione di “zone economiche esclusive” nel Mediterraneo orientale.
Sin dal fallimento degli accordi di Mosca del 13 gennaio (in cui si è tentato invano il raggiungimento di una tregua), è sempre più evidente come il conflitto sia legato a doppio filo a dinamiche che spesso si intrecciano e si sovrappongono. Lo si può constatare in entrambi i campi, ma soprattutto in quello di Haftar, il quale dipende sì dai supporti esterni, ma deve al contempo curare gli interessi delle milizie che è ruscito a federare. Allo stesso tempo, la molteplicità di stati che lo supportano gli permette un margine di flessibilità per imporre la propria agenda. In questo momento, egli combatte per la conquista di Tripoli, ed è molto vicino al traguardo. Dunque è ben difficile che voglia fermarsi: lo deve a Egitto, Russia, Francia ed Emirati, ma anche alle milizie che gli sono leali. E mai accetterà la Turchia come mediatore.
L’Europa, nonostante l’iniziativa di Angela Merkel, pare ancora costretta ai margini della questione. Forse perché ha considerato il caso libico solo in termini di contrasto alla migrazione?
Il problema dell’Europa è che non ha mai cercato di fornire una risposta unitaria alla crisi libica. I due principali attori europei in Libia, Francia e Italia, hanno espresso posizioni che riflettevano interessi opposti. La sola risposta unitaria data dall’Unione europea è stato il riconoscimento del governo di unità nazionale, senza tuttavia andare oltre, e lasciando prevalere gli interessi di Parigi e Roma. Distinti, contrastanti e, per quanto riguarda l’Italia, di corto respiro, improntati principalmente al controllo dei flussi migratori. Per contro, la Francia ha a sua volta sviluppato le proprie aree di interesse (dalle operazioni di contenimento e contrasto dei gruppi jihadisti alla vendita di armi a Egitto e agli Emirati). Avendo poi mire concorrenziali con quelle italiane in ambito energetico, ha puntato su Haftar come miglior partito tra quelli presenti nell’area.
In questo contesto, la conferenza di Berlino rappresenta il primo tentativo europeo di recuperare il tempo perduto. Senza però particolari garanzie di successo.

Un momento della conferenza di pace per la Libia svoltasi a Berlino (Keystone)
Quanto conta la disputa per le risorse? Non risolve tutta la questione, ma ne è una parte decisiva, mi sembra.
Le parti che si combattono hanno sicuramente interessi economici importanti, in gran parte legati al controllo degli idrocarburi, anche se non si deve ridurre interamente la questione alla dimensione energetica. In questo momento, vi sono due controversie che si sovrappongono senza essere per forza legate: da un lato, la questione del petrolio e del gas libici; dall’altra, la competizione regionale per le risorse del Mediterraneo orientale.
Quanto alla prima, abbiamo già detto che Francia e Italia hanno interessi precisi in Libia. A mio avviso, però, colei che risente maggiormente delle fluttuazioni delle produzioni nazionali libiche è la stessa popolazione libica, piuttosto che gli stati acquirenti. E in questo contesto, a rimetterci sono appunto i libici, come dimostra l’effetto disastroso dovuto alla chiusura dei terminali e di alcuni pozzi d’estrazione imposta dalle milizie fedeli ad Haftar, mirante a provocare il tracollo della produzione e a negare così i proventi della vendita del greggio al governo di Tripoli. Altrettanto importante è la partita nel Mediterraneo orientale, dove sono stati individuati rimarchevoli giacimenti di gas naturale, suddivisi (e contesi) tra Cipro, Israele, Libano, Palestina ed Egitto. È qui che si è accesa la questione del gasdotto EastMed – finanziato da Israele, Grecia e Cipro – che si propone come via di rifornimento all’Europa alternativa a quella del gas russo. Un progetto che presenta tuttavia importanti difficoltà ingegneristiche, a cui si legano le dispute politiche sorte dopo l’accordo tra Erdogan e al Serraj. Contratto non a caso immediatamente dichiarato nullo dagli stati che supportano il progetto EastMed. In questo frangente, la politica regionale di Erdogan gli impone di tenere in vita il governo di Tripoli il più a lungo possibile, per assicurarsi al contempo la sopravvivenza dell’accordo economico.
I gruppi jihadisti (anche quelli giunti dai campi siro-iracheni dopo la rotta dell’Isis) hanno trovato in Libia nuovo terreno di conquista. Quanto peseranno in un ipotetico quadro di riconciliazione nazionale?
Certamente possono costituire un ostacolo a ogni ipotesi di ricomposizione unitaria dello stato libico. Sono realtà pericolose, sia per l’eventualità di futuri attacchi, sia perché agiscono in aree del Nord Africa e nel Sahel praticamente indisturbati. Molto spesso si finanziano attraverso traffici illeciti e il mercato nero. Nel caso libico, questo quadro si osserva soprattutto al sud, dove nonostante il preteso controllo esercitato dalle forze vicine ad Haftar i confini restano estremamente porosi.
Quanto alla minaccia jihadista, c’è stato un periodo in cui combattenti provenienti da altri quadranti (soprattutto Siria e Iraq) sono tornati in Libia per sfruttare il momento di instabilità interna e tentare di insediarvisi. Da questa prospettiva, ciò rappresenta un problema per l’intera regione. Lo è, ad esempio, per la Tunisia : molti tunisini sono infatti partiti per formarsi militarmente all’estero e riportare in patria le capacità militari acquisite per tentare di stabilire una realtà affine alla loro ideologia. Lo dimostrano, del resto, gli attentati degli ultimi anni. Un problema noto anche per l’Egitto, il cui deserto è stato una importante via di transito dalla Libia al Sinai, dove sono insediati i principali gruppi jihadisti in lotta con il governo del Cairo. Possiamo quindi affermare che dove lo stato si sgretola e dove vi è mancanza di capacità e di mezzi per contrastarle, le sigle jihadiste riescono a condurre il proprio gioco. Tanto più se la loro organizzazione è radicata nel territorio.