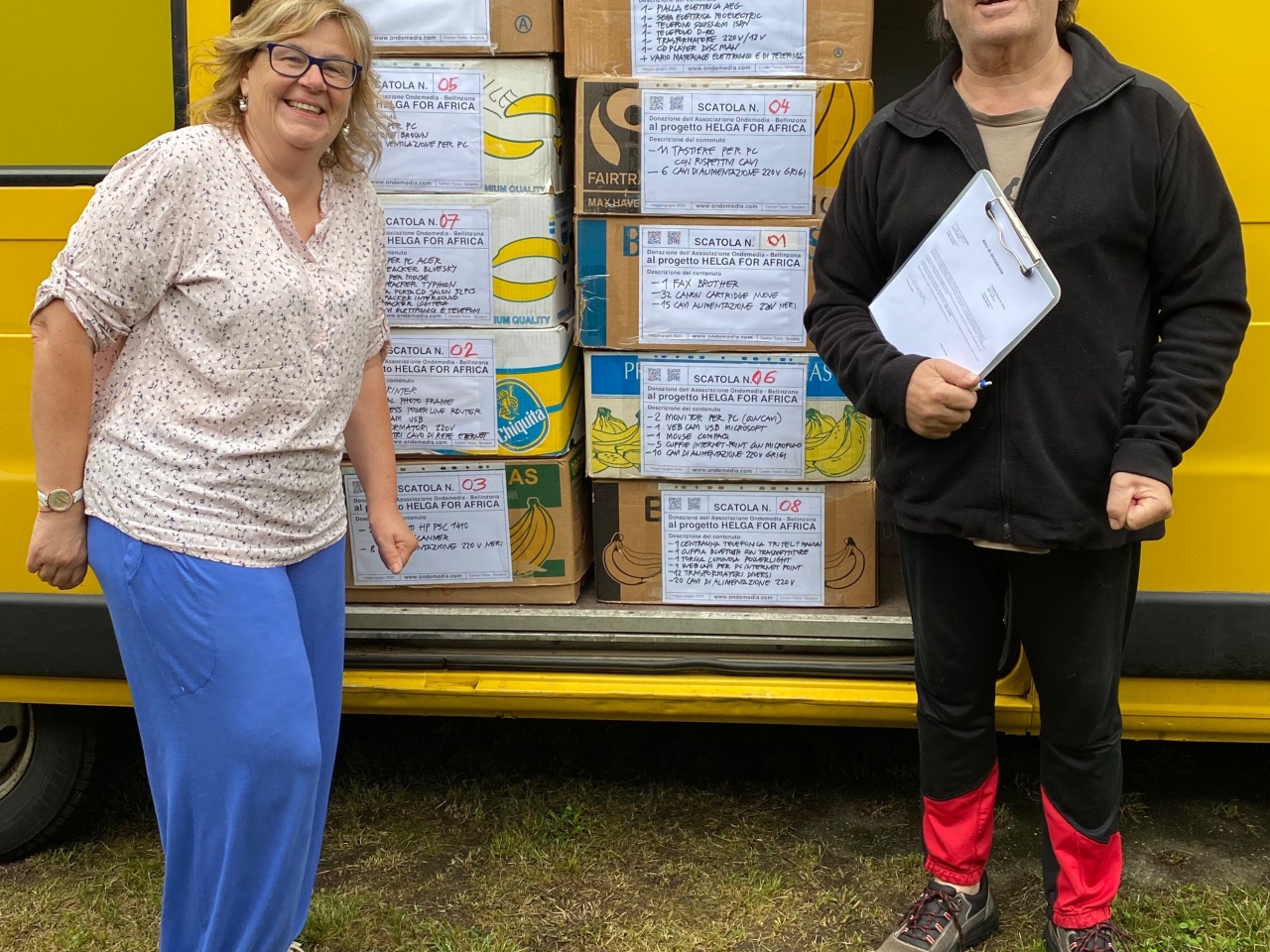Dentro il campo profughi, tante vite in sospeso
Dal Ticino al Burkina Faso, l'antropologa Bardelli racconta il dietro le quinte dei flussi migratori e anche perché chi vuole aiutare spesso fallisce

 Dentro il campo profughi, tante vite in sospeso
Dentro il campo profughi, tante vite in sospeso Lei nei campi profughi in Burkina Faso ci è stata, fianco a fianco ai rifugiati, ascoltando le loro storie, osservando come programmi umanitari possano anche favorire ineguaglianze. Sembra un controsenso ma aiutare non è facile. Vediamo perché con l’antropologa Nora Bardelli, ricercatrice al Centro di ricerche internazionali (Ceri) all’Istituto di studi politici di Parigi (SciencesPo). L'abbiamo incontrato a Lugano, dove era ospite del convegno organizzato dall’Associazione per l’aiuto medico al Centro America (Amca).
Come si vive in un campo profughi?
Si vive in tende spartane, c’è un semplice mercato, la chiesa o moschea, le docce. La gente chiacchiera e beve il tè coi vicini. C’è chi dà una mano, distribuisce cibo, porta i malati al centro sanitario, organizza eventi. Pensavo di trovare una prigione a cielo aperto, invece c’è molta vita, si nasce, ci si sposa. Ogni rifugiato riceve un mix di cibo (riso, fagioli, olio e farine proteiche) e soldi (3’500 cfa al mese, ne servono 650 per un chilo di zucchero. Sono 6 franchi). Spesso è più di quanto hanno nei villaggi limitrofi, dove l’Alto Commissariato dell’Onu (Unhcr) deve investire nello sviluppo (costruire scuole, strade) per evitare indivie e conflitti.
È una vita di attesa, quali le prospettive?
Ci sono campi profughi aperti da 20 anni che sono diventati città. Si aspetta che la guerra finisca per tornare a casa, ma il tempo passa e nulla cambia. Alcuni iniziano ad organizzare qualche attività, c’è chi fa e vende gioielli, chi acquista un pezzo di terra da coltivare. Sono vite sospese, in attesa, il contesto è difficile, ma nessuno si dispera, ci si adatta. I rifugiati in Burkina Faso possono lavorare, acquistare casa, l’unico diritto che non hanno rispetto ai burkinabé è votare.
Che cosa li spinge verso l’Europa, verso le diaspore, dove la qualità di vita non sempre migliora?
Ci sono tante ragioni. C’è l’idea diffusa che dove sta il bianco si sta meglio, perché quelli che conoscono in Africa hanno una vita più agiata. Sanno che è dura per i profughi in Europa, sanno che è rischioso partire, perché vedono le immagini alla tivù, ma è un rischio che sembra remoto. Inoltre i migranti già in Europa non raccontano sempre delle loro condizioni di vita. Non puoi lamentarti perché sei stato scelto e sostenuto dalla famiglia, dal villaggio. Anche per questo, c’è poco feedback. C’è chi scappa anche per il clima, c’è sempre meno acqua per le coltivazioni e le loro ricchezze naturali sono controllate da multinazionali europee.
Lei ha analizzato gli aiuti umanitari ai profughi, che cosa non funziona?
Alcuni progetti per promuovere forme di lavoro tra i rifugiati, pensati a Ginevra, non si adattano alla realtà del Burkina Faso. Ad esempio l’Unhcr ha realizzato una struttura al Nord per professionalizzare la produzione di latte, che era familiare. Hanno fatto vaccinare tutti gli animali, costruito fattorie con moderni macchinari per pastorizzare il latte. Una azienda che occupa centinaia di rifugiati, ciascuno formato per un ruolo specifico nella catena di produzione. Il problema è che non c’era il mercato. Dopo un anno il latte veniva venduto solo nelle mense dei campi profughi. Poi nemmeno lì, a causa di tagli. La struttura non è autosufficiente. Un progetto dell’Unhcr da 5 milioni di euro (donazione di Ikea) che non ha tenuto conto del contesto locale.
Quale è il problema? Voler applicare la mentalità elvetica al Burkina Faso?
Non si fanno studi abbastanza approfonditi per capire cosa sia davvero sostenibile e duraturo. Faccio un altro esempio. L’Unhcr ha detto ai profughi di chiedere un prestito in banca per aprire un’attività come vendere tessuti. L’agenzia Onu faceva da garante. Nessuno l’ha fatto perché ci vuole un piano finanziario ed i rifugiati con cui io ho parlato non sanno farlo, pochi sanno scrivere. C’è un’economia informale, senza ricevute e conti, ci sono i gruppi di quartiere che fungono da cassa di risparmio. In questa realtà il prestito in banca sanno chiederlo in pochissimi. Ultimo esempio, l’Unhcr ha aiutato 10 profughi a fare la patente, solo 4 hanno accettato. Il problema è che pochi hanno l’auto.
Che cosa significa vivere in Burkina Faso, lei ha rischiato la vita, ce lo vuole raccontare?
Avevo la malaria e la cura non ha funzionato perché il farmaco, acquistato in farmacia, era falso. Sono peggiorata velocemente. Dalla Svizzera i miei genitori hanno inviato la Rega, in 24 ore ero nel reparto di cure intense a Zurigo, fegato e reni non funzionavano più, fossi rimasta in Africa li avrei quasi sicuramente persi. Ero davvero messa male, ma alla fine l’infezione è arretrata e gli organi hanno ripreso a funzionare. Ho vissuto sulla mia pelle le diseguaglianze in Africa: un terzo delle morti per malaria è causato da farmaci contraffatti, invece del principio attivo c’è sapone o lisciva. È un traffico più redditizio di quello della droga. Sono sopravvissuta grazie alla ricchezza europea, che contribuisce a creare queste diseguaglianze ma che permette a noi di avere un servizio come la Rega.